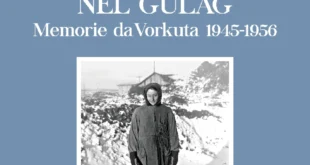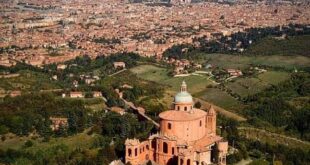di Lorenzo Berardi

‘Il bambino nella neve’ è un libro insolito nel panorama editoriale italiano. A metà strada fra autobiografia, reportage e racconto di viaggio, l’opera si muove fra coordinate che comprendono W.G. Sebald, Eraldo Affinati e autori polacchi come Filip Springer e Henryk Grynberg. E non è un caso che proprio in Polonia il suo autore sia nato e cresciuto, trasferendosi poi in Italia dove è stato per molti anni responsabile culturale del settimanale L’Espresso.
Come si può evincere dal suo cognome, Wlodek Goldkorn è di origine ebraica e ha trascorso l’infanzia fra Katowice e Varsavia, figlio di genitori sopravvissuti alla Shoah. I Goldkorn hanno lasciato la Polonia nel settembre ’68 in seguito alla oggi semi-dimenticata campagna d’antisemitismo scoppiata un anno prima e sancita da un comizio di Władysław Gomułka. Un periodo tumultuoso innescato da conflitti interni al partito comunista (Pzpr) che vide migliaia di ebrei polacchi emigrare alla volta di Israele per sfuggire a un clima fattosi spesso irrespirabile.
‘Il bambino nella neve‘ racconta questo e altri capitoli di storia familiare senza eccessi di vittimismo, ma con lucido raziocinio. Una cifra stilistica confermata anche nel prosieguo dell’opera quando l’autore allarga il campo e il respiro dell’ora completando un proprio ideale percorso. La narrazione è accompagnata e integrata dalle fotografie di Neige De Benedetti capaci di soffermarsi sull’efficace simbolismo dei luoghi attraversati, escludendo alcuna presenza umana.
Un’infanzia slesiana
Goldkorn comincia l’opera con piglio da reporter flâneur tornando nella sua casa d’infanzia a Katowice a mezzo secolo di distanza. Nella oggi dinamica città slesiana l’autore si ritrova smarrito, frastornato dai cambiamenti che hanno trasformato luoghi per lui un tempo quotidiani. L’elegante palazzo costruito appena prima della guerra in stile modernista che l’ha visto bambino e ragazzo è ancora al suo posto, quasi immutato. L’istituto scolastico nel quale Goldkorn ha studiato e che, ricorda: “era frequentato, quasi esclusivamente, da figli di comunisti e da ebrei” perché non vi si insegnava religione emana ancora “la sensazione di benessere che dà una buona istituzione”.
[…]
 East Journal Quotidiano di politica internazionale
East Journal Quotidiano di politica internazionale