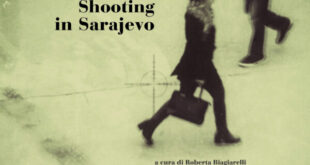Il tè è una delle bevande più popolari al mondo.
Ci rechiamo nel nostro negozio di fiducia, al mercato o al supermarket, compriamo il nostro pacchetto di tè preferito, lo prepariamo in pochi minuti e lo gustiamo, da soli o in compagnia, facendo due chiacchiere con gli amici nel nostro salotto di casa.
Procurarsi e bere il tè è facile e rilassante.
Ma da dove viene il tè? Qual è il costo sociale e umano che ci permette di bere questa bevanda? Quali sono le condizioni dei lavoratori nelle piantagioni di tè e che tipo di vita conducono?
Mai, in più di trent’anni mi ero posto queste domande: bevevo tè perché buono, salutare, veloce da preparare e perfetto per socializzare.
Lo bevo tutt’oggi: ma da tre anni a questa parte, nella mia tazzina di tè sono riflessi i visi e i colori dei sari delle donne di Srimangal che tutti i giorni, da marzo a metà dicembre, per una paga quotidiana che non raggiunge i cinquanta centesimi di euro, si spaccano la schiena per ore, sotto a un sole cocente, nelle verdi piantagioni del Bangladesh, per raccogliere con le loro delicate mani le preziose foglie dalle piante di tè.
Raccogliere le foglie di quello che sarà il nostro tè, non è né facile né rilassante.
Sebbene il Bangladesh produca meno del 3 % del quantitativo mondiale in un mercato in cui la Cina, l’India, e altri paesi asiatici la fanno da padroni, la coltivazione, la produzione e l’esportazione di tè ricopre un importante ruolo nell’economia nazionale e dà lavoro a centinaia di migliaia di persone.
La coltivazione del tè, introdotta nell’attuale Bangladesh dagli inglesi a partire dalla metà dell’ottocento, si sviluppò velocemente grazie a condizioni climatiche ideali per la crescita di questa pianta. A fine secolo le piantagioni erano già più di centocinquanta, un numero pressappoco simile a quello attuale.
La maggior parte delle grandi piantagioni di tè si trova nelle verdi colline che ricoprono le regioni nord orientali del Bangladesh, con l’eccezione di alcune piantagioni situate a sud est, nella regione di Chittagong.
Srimangal, nella regione di Sylhet, in prossimità con il confine indiano, è la capitale bangladese del tè. Tutta l’economia della piccola città ruota attorno al prezioso “oro verde”.
Poco è cambiato dai tempi in cui, nella seconda metà del XIX secolo, i primi latifondisti inglesi fecero arrivare nelle nuove piantagioni dell’attuale Bangladesh migliaia di poveri lavoratori indiani, già esperti, avvezzi alla fatica e allo sfruttamento per il lavoro svolto nelle piantagioni delle regioni indiane del Biahar, dell’Orissa o del Madhya Pradesh.
I proprietari delle piantagioni sono, ai giorni nostri come allora, grandi compagnie straniere, alle quali si sono aggiunte oggi imprese e piccoli latifondisti locali.
I manager di queste società vivono nelle loro opulente ville, dirigendo e supervisionando le operazioni per conto dei proprietari.
I lavoratori e le loro famiglie vivono, in scarse condizioni igieniche, in piccole case fatiscenti, in prossimità delle piantagioni e delle fabbriche del tè.
Quasi tutti di origine indiana ma ormai tagliati fuori dalle loro radici culturali, sono i discendenti dei lavoratori giunti più di un secolo e mezzo fa. Non parlano il bengalese, ma un hindi “sui generis”, una lingua parlata solo nelle piantagioni di tè del nord est del Bangladesh, oppure il Deshali, un mix tra la lingua bengalese e un dialetto della regione indiana dell’ Orissa.
Le loro condizioni di lavoro e di vita, grazie a un sindacato e alcune leggi che tutelano (o dovrebbero tutelare) i loro diritti sono leggermente migliorate ma, a distanza di più di un secolo, i lavoratori continuano ad esser quasi tutti illetterati come i loro antenati, che furono obbligati a firmare, da analfabeti, contratti che segnarono il loro destino e quello di intere generazioni di loro discendenti: un destino di stenti, un’esistenza passata a lavorare quasi come schiavi in cambio di salari da fame, che consentono a stento di sopravvivere.
La presenza di un dottore e l’istruzione elementare (ogni piantagione deve avere una scuola elementare per i figli dei lavoratori), a carico delle imprese proprietarie delle piantagioni e delle fabbriche di tè, è oggi garantita per legge ma, dato il contesto culturale e sociale delle loro povere famiglie, e il fatto che la maggior parte delle piantagioni si trovano in luoghi sperduti, difficilmente i figli dei lavoratori hanno la possibilità di andare al di là di una basica istruzione.
Le possibilità di un riscatto sociale sono prossime alla zero: i figli dei lavoratori del tè saranno, salvo miracoli, lavoratori del tè come i loro padri; già preparati al duro lavoro, rassegnati per “discendenza genetica” allo “sfruttamento”, per la gioia dei loro datori di lavoro.
La fase della raccolta delle foglie di tè è ancora oggi manuale in Bangladesh. Vi sono impiegate quasi esclusivamente donne, preferite per la loro velocità, la delicatezza del tocco delle loro mani che non danneggia le foglie, oltreché, purtroppo, per un salario inferiore a quello percepito dagli uomini.
Ecco a voi gli sguardi, i sorrisi, i rapidi movimenti delle mani, gli sgargianti colori delle vesti che da un lontano giorno dell’ottobre 2010, trascorso nelle verdi piantagioni di Srimangal, si riflettono nei miei pensieri, ogniqualvolta mi appresto a bere una fumante tazza di tè…: qui il reportage fotografico
 East Journal Quotidiano di politica internazionale
East Journal Quotidiano di politica internazionale