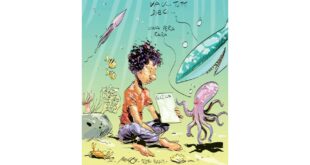Ci sono parole che non sono parole. Meglio, ci sono parole che non sono solo parole. Sono quelle che esprimono anche un sentimento, uno stato d’animo, un modo d’essere e di agire. Sentimenti, stati, modi che non potrebbero essere altrimenti espressi se non da quella parola lì e da quella soltanto. Chi mastica un po’ di lingue altrui sa che ognuna di esse ha le sue e che la loro traduzione è pressoché impossibile se non attraverso circonlocuzioni, a volte lunghissime, spessissimo imprecise.
In albanese una di quelle parole è “besa“, uno dei principi cardine del Kanun, il più importante codice di diritto consuetudinario albanese. Letteralmente significa “mantenere la parola”, ma essa va oltre la definizione, è molto di più: Besa è un codice d’onore, di più, un codice etico, il più alto nel paese. Chi agisce secondo la Besa è qualcuno che non solo mantiene la propria parola, ma è anche qualcuno a cui si può affidare la propria vita e quella della propria famiglia.
La storia
Con l’ascesa di Adolf Hitler al potere all’inizio degli anni ’30 del secolo scorso, l’Albania è diventata il rifugio di molti ebrei in fuga dalle persecuzioni naziste, anche attratti dalla possibilità concessa loro da Re Zog di ottenere un passaporto albanese in cambio del loro contributo allo sviluppo del paese – sebbene per molti ebrei quella fosse considerata solo una tappa intermedia verso altre destinazioni, Israele in primis (persino Albert Einstein transitò da Durazzo per tre giorni, nel 1935, prima di trasferirsi negli Stati Uniti). Il numero complessivo non è noto con esattezza ma si stima che siano stati circa un migliaio (600-1800) gli ebrei che giunsero in Albania – a sommarsi ai duecento ebrei albanesi, una piccolissima minoranza se si pensa che la popolazione albanese dell’epoca era già di oltre 800 mila persone. Era un mondo variegato e trasversale, in arrivo dall’Europa “vicina”: Serbia, Bosnia, Montenegro, Grecia, oltre che, naturalmente, da Germania e Austria. Erano per lo più mercanti, imprenditori e negozianti, molti gli studenti, tantissime le donne e i bambini. L’integrazione con la popolazione locale non fu difficile in un paese fondamentalmente tollerante delle differenze religiose e, forse anche in ragione dell’esiguità dei numeri, privo di sentimenti antisemiti radicati.
I problemi per gli ebrei albanesi iniziano, però, con l’occupazione fascista nel 1939 che diede l’abbrivio alla loro persecuzione. C’è infatti un pezzo di storia scomoda e ancora poco raccontata che ci riguarda e che parla dei campi di concentramento italiani in Albania: ce ne sono almeno cinque attivi tra il 1940 e il 1941, uno di questi è quello di Kavaja, città a sud di Tirana. È a Kavaja che, nel luglio del 1941, quasi duecento ebrei vengono deportati temporaneamente prima di essere trasferiti in Italia presso il campo di Ferramonti di Tarsi, in provincia di Cosenza.
Ma è soprattutto alla fine del 1943 quando le truppe tedesche entrano in Albania a seguito dell’armistizio dell’8 settembre e del “rompete le righe” dell’esercito d’occupazione italiano, che la situazione per gli ebrei in Albania prende una piega drammatica. Siamo infatti nel pieno del programma di sterminio sistematico della comunità ebraica, della Shoah, un programma portato avanti scientificamente, ovunque in Europa. L’Albania non fa eccezione.
Besa, la parola magica
Non si fanno i conti con la besa, però: quella gente è arrivata in Albania per trovare salvezza e non è quindi possibile metterli nelle mani dei propri carnefici. I nazisti chiedono al governo albanese l’elenco degli ebrei nel paese, vogliono nomi e cognomi. Quei nomi e quei cognomi, però, non vengono fatti, così come era già successo per l’analoga richiesta italiana: nessun elenco viene condiviso. Una cosa tanto più sorprendete se si pensa che il governo in carica era quello collaborazionista e filo-fascista di Mehdi Frasheri che, abbandonata la lotta partigiana, aveva trovato rapidamente il modo di mettersi d’accordo con i nuovi occupanti. Invece si mobilitano persone di ogni ceto ed estrazione sociale – l’élite borghese i contadini, gli insegnanti – e persino di ogni religione, i musulmani, i cattolici.
Viene fornita protezione, rifugio, assistenza. In molti casi funzionari conniventi riescono a procurare documenti falsi, a regalare una nuova identità e una nuova vita. Una speranza di anonimato. Una mobilitazione che si attua anche in Kosovo, all’epoca parte integrante della Grande Albania, dove se è vero che le SS naziste riuscirono comunque a condurre drammatici rastrellamenti a Pristina e Mitrovica (furono centinaia gli ebrei deportati in Serbia e poi in Germania), è altresì vero che decine di famiglie furono nascoste, tutelate e supportate dalla popolazione locale.
La maggioranza degli ebrei si salva al punto che l’Albania è “l’unico paese con più ebrei dopo la seconda guerra mondiale” come ha affermato il primo ministro del paese, Edi Rama. E non è un caso, a tal proposito, che la Yad Vashem, l’Ente Nazionale per la Memoria della Shoah a Gerusalemme, abbia insignito ben 75 albanesi del titolo di “giusti”, un numero ragguardevole se si pensa all’esiguità della comunità ebraica in Albania.
Il monumento a Tirana
Oggi quell’atto di straordinaria solidarietà e di eccezionale umanità e coraggio è diventato un monumento collocato all’ingresso del Parco del Lago Artificiale di Tirana, vicino a Piazza Madre Teresa e finanziato dalla Commissione degli Stati Uniti per la conservazione del patrimonio americano all’estero e dal Comune di Tirana.
Tre lapidi in marmo grigio opera dell’architetto Stephan Jacob recanti un’iscrizione in inglese, ebraico e albanese per onorare “gli albanesi, cristiani e musulmani che hanno messo in pericolo la loro vita per proteggere e salvare gli ebrei”. La cerimonia di inaugurazione del memoriale il 9 luglio scorso è avvenuta alla presenza di Edi Rama e del sindaco di Tirana, Erion Veliaj, nonché dell’ambasciatore israeliano in Albania, Noah Gal Gendler, che ha parlato di “un eccellente esempio da un piccolo paese che evidenzia i valori di umanità, sacrificio e amore, valori che sono ancora fondamentali in Albania”.
E’ stata però l’ambasciatrice degli Stati Uniti, Yuri Kim, a sottolineare che tutti quei valori in Albania si riassumono in una parola sola: besa. La parola che non è solo una parola.
Nella foto (AP News) l’ambasciatore israeliano Noah Gal Gendler
 East Journal Quotidiano di politica internazionale
East Journal Quotidiano di politica internazionale